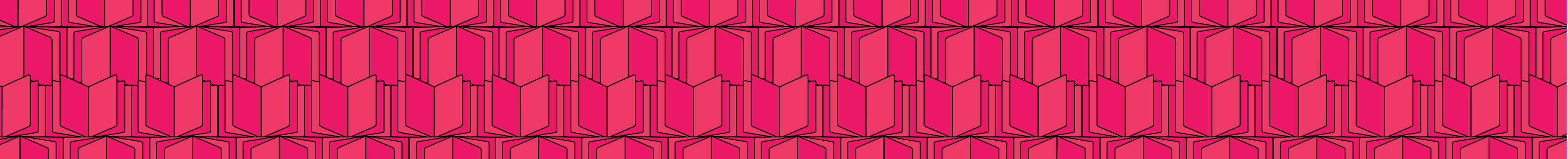Marco Aime Gennaio 2018
In un’epoca post-razziale come quella in cui viviamo oggi, anche il lessico dovrebbe inventare nuove strade. Espulso dalla scienza, il concetto di razza ha però trovato nuove declinazioni a cui forse bisognerebbe trovare nuovi nomi. Non è bastato che la moderna genetica abbia decostruito l’idea di razza, per fare scomparire il “razzismo”. Perché è lì che sta la radice: è il razzismo che ha prodotto l’idea di razza e non viceversa. E oggi produce nuove forme di discriminazione e di esclusione, che stanno pericolosamente risorgendo dopo mezzo secolo di apparente oblio.
L’Italia aveva già dato prova di razzismo con l’emanazione delle leggi razziali nel 1938 sotto la dittatura fascista. Dopo l’immane tragedia della Shoah si pensava che quello fosse un episodio archiviato per sempre nei polverosi archivi della storia. Invece, negli ultimi tre decenni si è assistito al progressivo emergere di gruppi e movimenti politici che, alle grandi narrazioni del Novecento, su cui si fondavano le ideologie classiche, tanto liberale quanto quella socialista, hanno sostituito una nuova proposta: quella etnica. Nuova, ma in realtà vecchia, infatti, una proposta politica che si affaccia sul mercato deve presentarsi con una buona dose di consolidamento storico e con un’altrettanta buona dose di potenzialità innovative. Ecco che, se da un lato si strizza l’occhio alla storia, dall’altro si lanciano idee nuove, o in grado di apparire tali[1].
Puntando su valori come identità, radici, autoctonia e proponendo l’immagine di popoli nuovi, fasulli per la storia ma antichi e reali nelle retoriche adottate, tali movimenti, come la Lega in Italia, hanno arricchito il panorama politico con categorie inedite, che spesso sfuggono all’analisi tradizionale. Le incertezze e i cambiamenti indotti dalla globalizzazione, dalle migrazioni e dal venire meno del welfare, hanno fatto crescere una vera e propria «ossessione identitaria»[2] sta alla base delle politiche localistiche che non di rado si traducono in forme di esclusione, di xenofobia, e talvolta sfociano in un vero e proprio razzismo, sfruttando il fertile terreno del debole senso di appartenenza nazionale di gran parte degli italiani e le paure nei confronti degli stranieri, per lo più indotte da campagne mediatiche strumentali.
Se si ripercorre il cammino di costruzione dell’immaginario leghista, delle retoriche che lo accompagnano, ci si trova a fare i conti con un continuo oscillare tra concezioni vecchie presentate come novità e, viceversa, elementi nuovi presentati come tradizionali. L’attacco alla nazione, creatura e vanto dell’Occidente «civilizzato», forse non è un ritorno al passato, ma una cifra della nostra modernità, perché «la moltiplicazione degli scontri etnici, culturali o religiosi nel mondo non corrisponde affatto a un ritorno indistinto della tradizione, ma indica, al contrario, la situazione di balcanizzazione globalizzata nella quale ci troviamo».[3] Una situazione di progressiva etnicizzazione delle società, che per certi versi produce un ritorno a forme di tribalismo.
L’emergere di localismi sempre più estremi e di istanze di tipo etnico, che spesso sfociano nel razzismo, coincide con il declino del sociale. Le aggregazioni orizzontali classiche, su base sociale, ideologica, di classe, vengono sostituite da tagli verticali, che classificano sulla base del legame tra terra e sangue, sul principio dell’autoctonia o della cultura. Il venir meno delle grandi narrazioni e la frammentazione dell’economia hanno reso apparentemente obsolete le rivendicazioni tradizionali.
Le identità frammentarie, liberate dagli ideali universalisti, sono divenute nicchie di difesa. L’identità individuale, icona della nostra postmodernità, necessita a sua volta dell’installazione di un apparato logistico, di una serie di punti di riferimento teorici e pratici, che ne supportino la costruzione e il mantenimento in vita. Nascono così nuovi attori, incaricati di sostenere individui resi fragili dalla scomparsa delle strutture collettive di aggregazione. Come osserva Jean-Loup Amselle, individuo, cultura e ritorno all’origine sono le parole d’ordine nella postmodernità globalizzata. Poiché la sorte degli abitanti del pianeta non può più essere migliorata con la ridistribuzione dei proventi della crescita, occorre trovare nuove ideologie che facciano leva sulle risorse identitarie, culturali, psichiche dell’individuo, il modo di sostituire la defunta narrazione della società dell’abbondanza. Sono queste le caratteristiche della «new age» tribalizzata e primitivizzata che ci viene offerta. Ma le tribù di cui stiamo parlando sono raccolte di individui che hanno ben poco a che vedere con quelle descritte dall’antropologia tradizionale. La cultura di questi gruppi non si fonda, infatti, su una vera tradizione condivisa, ma è il prodotto di scelte individuali di identificazione, radunate in insiemi collettivi temporanei e costruiti allo scopo di soddisfare interessi specifici. Nelle retoriche politiche dei movimenti, che fanno dell’identità il loro fulcro, possiamo facilmente notare come quell’identità sia spesso contornata di termini tra il romantico e il nostalgico, ad esempio popolo, tradizione, e il possessivo “nostro” la faccia da padrone in ogni frase. Basti pensare a certe richieste della Lega Nord sul diritto ad avere maestri, magistrati, funzionari autoctoni.
L’eccessiva sovraesposizione dell’identità, di una identità, rischia di trasformarci in esseri unidimensionali. Il problema è ancora più grave se l’unica dimensione in cui si finisce per essere inglobati è quella etnica, tribale. Letta in questa chiave, secondo cui gli individui sarebbero succubi, ingabbiati nella loro tradizione e incapaci o impossibilitati a cambiare la loro visione del mondo, la cultura parrebbe essere un dato ascritto, legato al territorio, quasi un carattere genetico a cui non è possibile sfuggire.
La tendenza a “naturalizzare” è sempre più forte e sempre più spesso si mette in atto quella finzione che trasforma la nascita in nazione o in comunità. Da elemento socialmente e storicamente costruito, la cultura finisce per essere invece concepita come un dato «biologico». Si dice cultura, ma si pensa razza, e una concezione razziale della cultura può portare anche a una sorta di razzismo senza razza.
Marco Aime insegna antropologia culturale presso l’Universitá di Genova.
[1] M. Aime, Verdi tribù del nord., Laterza, Bari, 2012.
[2] F. Remotti, L’ossessione identitaria, Laterza, Bari-Roma, 2010.
[3] J.-L. Amselle, Connessioni, Antropologia dell’universalità delle culture, Bollati Boringhieri, Torino, 2001, p. 44.